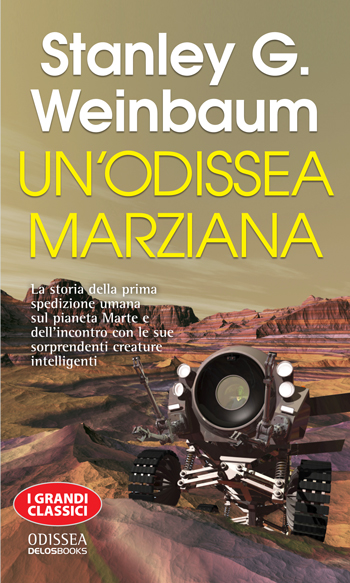Spirito di Napa Tei è il romanzo d’esordio di Lars Schlichting, che al primo colpo conquista una pubblicazione su Urania. Non è da tutti.
Autore svizzero di lingua italiana, ho avuto modo di ascoltarlo in una conversazione nell’ambito del Festival Altroquando 2023, in compagnia dell’illustratore Daniele Gay e con la moderazione di Giovanni Valerio, che ha suggerito il tema dei costruttori di mondi.
Ed è proprio la costruzione del mondo a costituire il punto forte di questo romanzo. L’aspetto che mi è piaciuto di più è infatti la scoperta dei pianeti presenti nell’universo costruito da Schlichting, un universo molto ricco e articolato, direi proprio complesso, sia dal punto di vista biologico che da quello politico. Ma l’autore guida il lettore con delicatezza: si scoprono i dettagli piano piano, in compagnia dei protagonisti.
Il personaggio principale, Will, è un terrestre che non ha mai lasciato il pianeta e si trova catapultato in un viaggio che dura diversi mesi, per raggiungere una stazione spaziale interrazziale. Nel lungo romanzo (circa 500 pagine) Will cambia molto. La scoperta dei mondi che visita e del loro passato lo porterà a cambiare radicalmente alcune idee. Il lettore lo accompagna e lo segue da vicino. In questo modo, leggendo si scoprono i dettagli con facilità e con piacere.
Nella lettura, ho trovato anche qualche punto debole o che non mi è piaciuto.
A livello di trama, ho trovato gli alieni un po’ troppo umani nei loro comportamenti e nelle loro reazioni. Problema molto difficile da risolvere, peraltro.
Avrei inoltre preferito una conclusione più trekkiana, più orientata alla scoperta di culture che alle battaglie stellari (la cui giustificazione mi è parsa forzata). Ma è questione anche di gusti.
Gusti che mi portano a una riflessione a livello più tecnico: credo che una sfoltita avrebbe permesso di guadagnare ritmo nell’ultima parte, che tende a trascinarsi senza che un capitolo aggiunga molto al precedente. Ma forse è un’impressione dovuta al fatto che quella delle battaglie è la parte che mi ha preso di meno.
Sempre sul tecnico, ho avuto la sensazione che il punto di vista, soprattutto nella prima parte, subisca dei cambiamenti troppo inaspettati e non sempre la motivazione ne è chiara. In alcuni casi, l’impressione è che si sia cercato di dare più dettagli ritornando su eventi già capitati da altri punti di vista, ma in alcuni casi ho trovato che questo stratagemma rallentasse il ritmo nella lettura di quello che è un romanzo d’avventura.
Nel complesso, comunque, ribadisco che si tratta di un bel romanzo, scritto con passione e inventiva, che sa trasmettere quel senso di meraviglia che rende la fantascienza un genere così appassionante.
Lars Schlichting, Spirito di Napa Tei, Urania luglio 2023